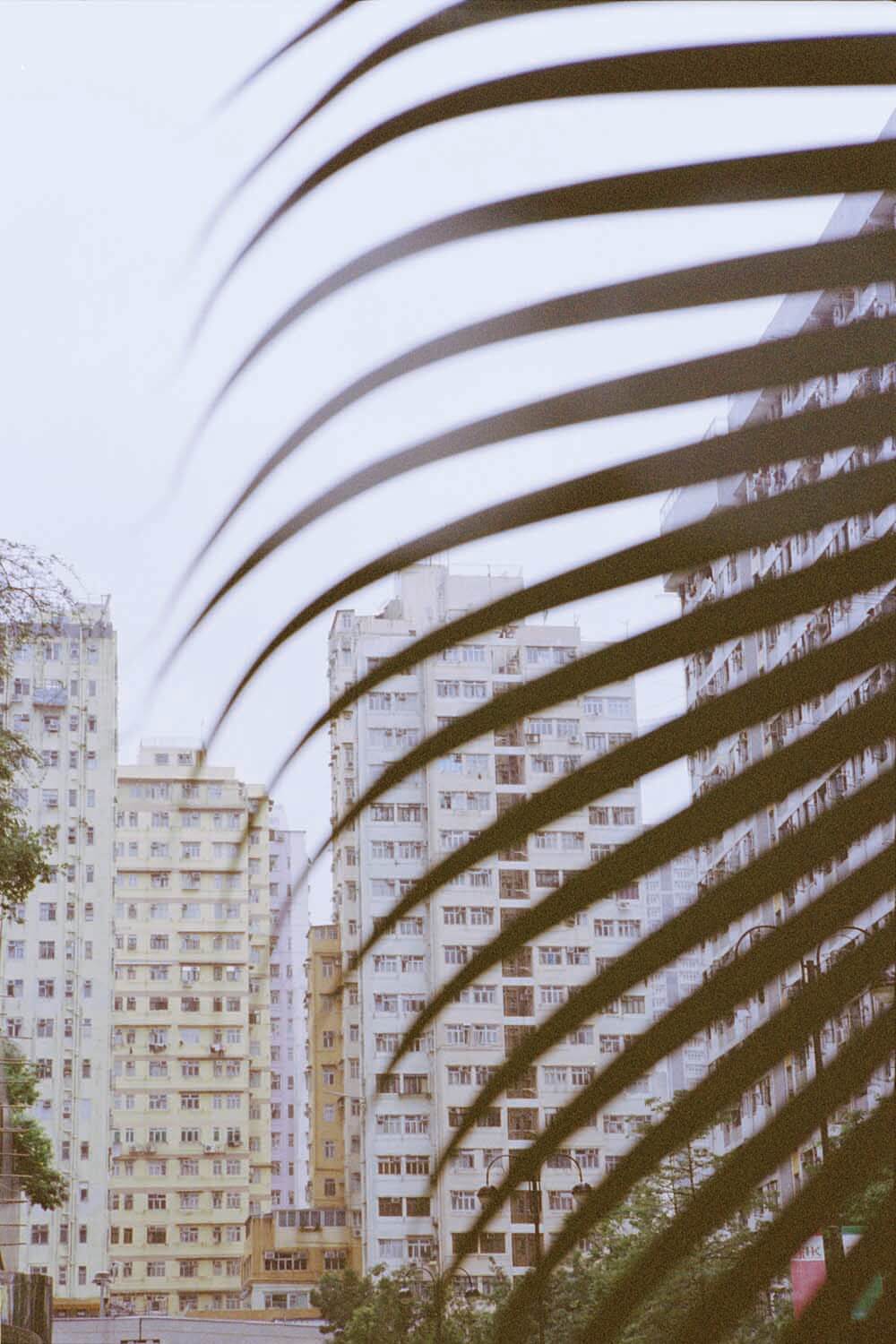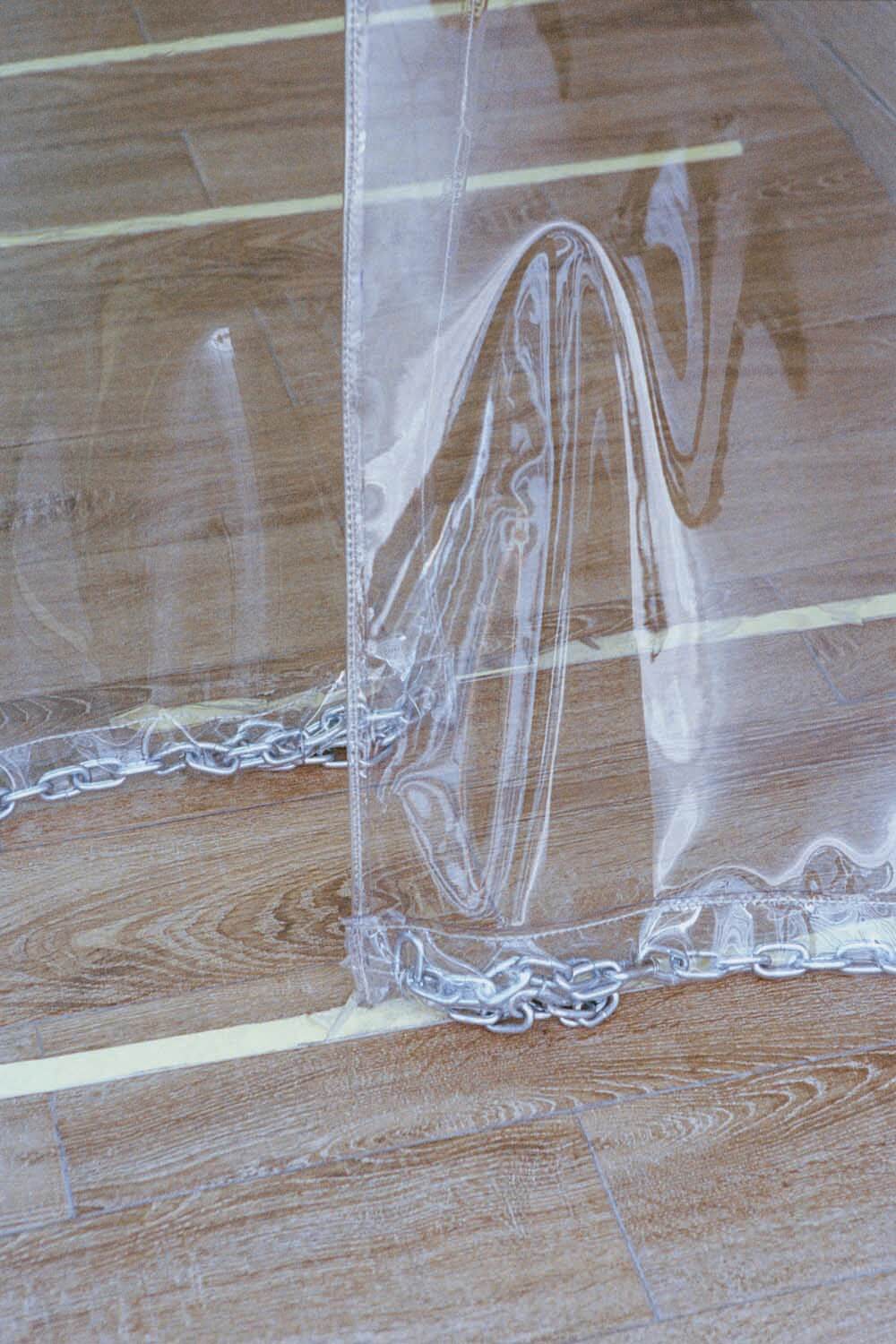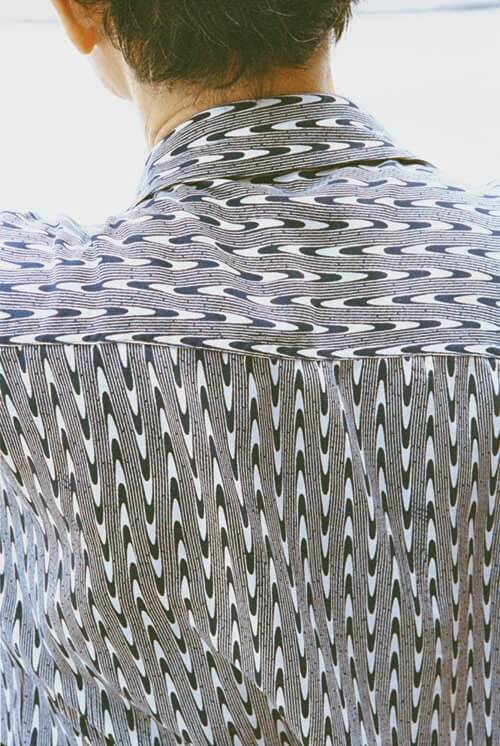“Una decina di minuti di metropolitana, un compendio su piccole cose corporali, paradigma di molto altro a Hong Kong.”
Il convoglio si scuote tremando come la carlinga di un aereo in volo, e lì, davanti a me, un esercito sonnolente, innocuo, aperto a ogni giudizio. Scendendo nella metro di Hong Kong si viene assaliti dai visi, un campionario di maschere lucide illuminate dall’alone medio dei neon. Se pur profani di questi lineamenti, sotto la luce impietosa si possono notare le piccole varianti che fanno la gradazione di una possibile bellezza. Questi particolari si palesano molto e bene, in quanto tutti i visi sono come plasmati da un calore. Ad esempio le palpebre si può dire siano quasi inesistenti, esse calano come una tenda di gomma solo quando l’occhio è chiuso, altrimenti scompaiono ben riposte dietro lo sguardo che punta triste su qualcosa che solo il cervello vede: perché quello che vedo qui, è un vedere pensato, gli occhi non osservano mai quello che indicano, sono tutti calmi ma sovrappensiero. Anche gli zigomi esistono nella forma di un bulbo lucido, una massa tonda e perfetta, sono la conferma che il sorriso qui, non è creatore di rughe, segni, linee scritte dell’accaduto, ma è una forza che muove delle masse di carne, come delle pietre levigate da un fiume, che scorrono placide sulle loro facce.
In una situazione così nitida, scultorea, voi capite come anche la minima imperfezione, ad esempio quella di due occhi troppo stretti sul naso o di un collo poco sviluppato, diventino una specie di tragedia. E ognuna di queste possibili note stonate, ogni piccolo stridio d’imperfezione fisiognomica, è un’arma carica, un detonatore che può dispiegare la forza di un’analisi. Il viso è un elemento carnoso, turgido, e gli occhi, quasi sempre scurissimi e dalla pupilla insondabile, vivono nel bianco laccato della loro sclera, si muovono come quelli di un cucciolo in salute, oppure in altri casi si alzano verso i miei, quasi al rallentatore, stanchi, pervasi da un color caramello mescolato a qualche piccola vena che rende l’occhio spento, stantio, come triste di una morte. Al minimo starnuto la faccia si sconvolge come dopo un pianto e servirebbe un lavandino qui nel vagone per mettere le cose a posto.
Tutti i volti sembrano ben poco mutati dalla nascita, hanno qualcosa di neonatale. A guardarli appaiono sempre nel loro quinquennio migliore, o nel peggiore dei casi sono di un’età indefinibile. I movimenti sono minimi, tutti sembrano pervasi da un intento, tutti dallo stesso – sebbene non si sappia quale – questo scopo misterioso e quotidiano li concentra, li immobilizza in quella che sembra un’operazione di risparmio energetico.
A ogni curva nel sotterraneo le teste oscillano e i corpi si muovono fluttuanti come gli archi di un’orchestra, sincronizzati come un branco di pesci, si potrebbe definire questa come un’unità, ma non lo è. Nonostante il vagone li scuota tutti insieme, anche in maniera brutale, essi rimangono annegati, circoscritti senza scampo nel da farsi: è come una catena di montaggio del pensiero, un’apnea intellettiva con una sua sub-attività invisibile, che spinge in uno stato di catatonia, di concentrazione granitica che non si può scalfire. La fronte è il totem di questa sovrastruttura mentale, una pietra immobile, ignara di ogni stato d’animo, la fronte è la bandiera di ognuno di questi volti, che sembrano non sfiorire mai, sembrano modellati da anni di sonno, e le teste, tutte insieme, galleggiano caotiche e armoniche come la schiuma dentro una bacinella profumata.
Alcuni sono entrati di corsa dopo l’ultimo stop, tra loro una donna. Qualcuno la urta, lei, immobile. Fuori deve aver iniziato a piovere, i suoi capelli bagnati sono lucidi e corti, una corona fusa intorno al cranio che scende e si pianta nel collo magro insaccato come un capitello rovesciato dentro la finitura di un impermeabile. È una statua esile. Una specie di energia si spande nella scena come un ossigeno, si allarga lenta e prende piede come una macchia d’acqua scura su un tessuto. Una visione, una vera visione, un’unica forma sacra di bellezza continuativa senza appigli al reale. Gli occhi scuri sono assoluti, con qualche goccia d’acqua sulle ciglia che fibrilla in tiro. Sogno di vederla piangere per poter accarezzare con le nocche il letto concavo della sua tempia, dove, accanto all’orecchio, sullo zigomo, i capelli neri terminano in un ciuffetto a forma di mezza luna fradicia che, come è tipico, non sfocia in nulla oltre la sua punta, perché sotto, la guancia, è una discesa perfetta.